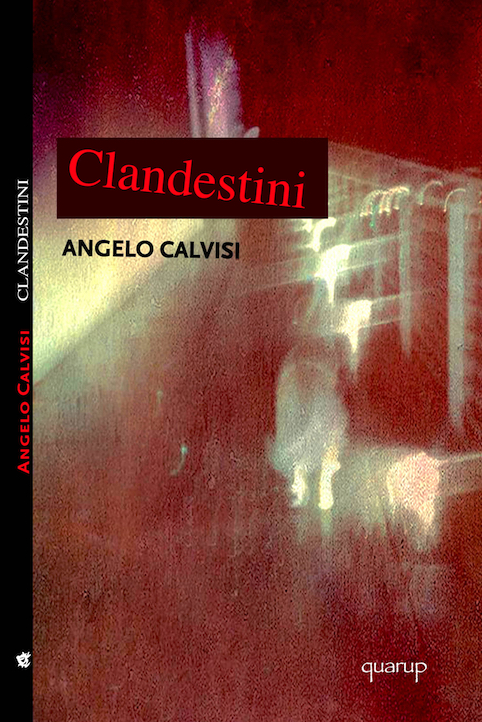di Claudio Bagnasco
Uscito nel marzo del 2016 per Quarup, Clandestini raccoglie otto racconti scritti da Angelo Calvisi, sette dei quali già pubblicati – in una versione primitiva – su riviste o blog letterari (questo blog ne ha ospitato quattro, qui, qui, qui e qui).
Le narrazioni sono inframezzate da sei Ipocalissi, brevi testi dalle atmosfere più disparate (si va dal resoconto di un funerale a quello di un’esistenza consumata su un asteroide contenuto nell’acqua di un bicchiere) ma tutti sorretti da una spiccata capacità affabulatoria e vivificati da un finale inatteso.
Spiccata abilità affabulatoria che accomuna anche i racconti lunghi. In Eravamo nel bosco ci troviamo, nuovamente, a un funerale; quello di Silvano, morto prima di poter esordire, ottantanovenne, con un memoir. Già la frase d’attacco mostra una delle caratteristiche salienti dello stile di Calvisi: l’utilizzo di un elemento anche minimo (in questo caso l’aggettivo patetico) che ha il potere di sommuovere un’intera frase, rendendola ora grottesca ora scopertamente comica: “Le luci pallide dei lampioni soffondono Roccarda di un alone patetico. Sono le sedici e quarantaquattro”, p. 11.
Cenni su mio fratello e sul resto della mia famiglia è una retrospettiva tragicomica del concepimento, della nascita e dei primi anni di vita del protagonista, dominata da un ritmo travolgente: “La torma aveva avuto via libera e dilagava da qualche minuto in senso ascendente quando la mamma, con una lavanda di acqua e sapone, tentò un reciso diniego all’irrimediabile disegno degli eventi. Quasi tutti i girini fecondatori cominciarono così a scivolare sulle mucose, pattinavano insensibili ai richiami dell’ovulo e quindi giù, dopo essere usciti dalla selva di labbra ed epitelio, erano risucchiati dalla pozzetta del water, elevando tenui mormorii di stupefazione nell’avvio del loro girotondo all’interno delle condotte”, p. 21.
Giornata tipo di strenuo cooperatore sociale è attraversato anch’esso da una vena ironica, che in questo caso vira verso l’amarezza: “Mi soffermavo sui dettagli delle mani, sulla pelle. Le macchie dell’età sul dorso, le vene esauste, le grinze. Mi soffermavo sulle dita, sulle nocche, sulla lunghezza e la forma delle unghie. L’essere umano da vecchio è ripugnante, mi dicevo, e questi due esemplari mi facevano particolarmente schifo. Tuttavia dovevo sforzarmi di essere gentile”, p. 32.
In Ipossia da corsa con rappresaglia di pastore si potrebbe quasi dire che la vicenda (la corsa a perdifiato, e zeppa di imprevisti, di un trail runner) sia composta di puro ritmo: “Uno sparo secco, gli uccelli, frullando, escono fuori dagli alberi. Un altro sparo, stessa provenienza, cioè dalla parte destra del crinale. Scendo giù dal lato opposto, dove le schioppettate non possono raggiungermi. Io guardo dove metto i piedi, anzi guardo proprio i miei piedi, calzano scarpe da corsa della marca Mizuno. Un barlume di ossigeno pescato non so dove approda al mio cervello e d’un tratto mi sovviene che sono un runner. Sono magrissimo, gambe magre, braccia magre, il torace naviga dentro la canottiera. Il pacco invece è ingombrante, nei miei pantaloncini ci sta stretto. Prendo una storta alla caviglia, una distorsione, termine più tecnico, e sento il terzo sparo”, p. 42.
Ne La ruota della fortuna Mohamed, un giovane giordano emigrato in Italia, è ingiustamente accusato di omicidio; in fuga, vaga nelle condotte fognarie, sino a ritrovarsi nello studio di registrazione del suo programma preferito, che non si rivelerà all’altezza dei suoi sogni (qui e in seguito, corsivo nel testo): “Prima che il servizio d’ordine mi blocchi riesco a vedere la bellissima Victoria che però non ride ed Enrico Papi che però è arrabbiato e il pannello spento della frase misteriosa e la ruota immobile e l’intero studio dove si registra la puntata della Ruota della fortuna che è molto più piccolo di come si vede in televisione ed è triste e ha il sapore di un circo”, p. 61.
L’avvincente biografia di Francesco Rossi è riportata in Farfalle con uno stile tra la cronaca e l’enciclopedia biografica, movimentato però dalla solita ironia di Calvisi, che stavolta è tenue, malinconica: “Francesco Rossi nasce a Castagneto, nel cuore della Maremma livornese, il mattino del 12 marzo 1880. Nel pomeriggio dello stesso giorno un foltissimo sciame di farfalle bianche invade il paese e lo sospende per alcune ore in un’atmosfera di sogno. La circostanza viene interpretata dalla famiglia come una sorta di benvenuto elargito dalla divinità al nuovo nato”, p. 64.
Ironia che, invece, si fa feroce in Music store: “Ho preparato un demo e l’ho spedito a una casa discografica. Avevo all’incirca vent’anni. La casa discografica mi ha chiamato, ha organizzato qualche serata. Sono stato anche in televisione, in prima serata, nel programma abbinato alla lotteria Italia. Ero sul punto di diventare famoso.
Poi è successo qualcosa. Non so bene. Qualcuno ha posto un veto. Che veto? Chi ha usato questa parola di merda? Insomma, avevo all’incirca vent’anni e alla fine mi sono ritrovato a lavorare in un negozio di CD, ottocentoquaranta metri quadrati disposti su tre piani. Vorrei l’ultimo dei One Direction. Tieni, e muori”, pp. 76-7.
Chiude la raccolta Missione a Berlino di un redattore suicida, nel quale l’io narrante si reca nella capitale tedesca con la propria compagna, Angela, per rintracciare Simone Specos, anziano scrittore ritiratosi dal mondo. La frase che Specos pronuncia nell’ultima pagina di Clandestini può assurgere a paradigma dell’intero libro (se non della scrittura stessa) di Angelo Calvisi: “Specos, accanto a me, affacciato alla ringhiera del terrazzo, indica un punto lontano che non riesco a distinguere. – È accaduto qui, – dice – è accaduto tutto qui, eppure nulla è esistito, nulla ha avuto importanza”, p. 89.
Le situazioni che coinvolgono i personaggi di questi racconti, infatti, non sono mai commisurate ai loro strumenti (perché troppo grandi o troppo piccole, troppo vicine o troppo lontane, troppo drammatiche o troppo ridicole).
Allora, se l’unico tentativo di catturare barlumi di senso può avvenire per sottrazione, adoperando le varie declinazioni dell’ironia, è tuttavia possibile assecondare il movimento della vita. Come? Attraverso il ritmo, che non a caso è il vero protagonista dell’opera di Calvisi.